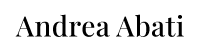I Luoghi del Mutamento
La serie dal titolo “I Luoghi del Mutamento”, iniziata nel 1988 e ancora in corso, è indubbiamente il progetto di maggiore complessità e anche il più noto di Andrea Abati: una serie di immagini di grande formato dove urgente è l’attenzione al paesaggio industriale contemporaneo e ai mutamenti della realtà sociale. Nelle fotografie della serie “I Luoghi del Mutamento”, Abati ha voluto come luogo di indagine Prato, la sua città natale, nella quale l’intrusione dell’industria nel contesto cittadino è forte e evidente. Abati ha fotografato la demolizione e ricostruzione di edifici industriali di Prato, dandone una visione lucida, serena e apocalittica, come quasi rovine di guerra, creando immagini dai colori stridenti, che fanno emergere i contrasti dei volumi e danno nuova linfa agli spazi industriali. La rapidità, che le necessità della società contemporanea impongono alla produzione e al ritmo del lavoro, fa sì che la realtà industriale sia uno specchio fedele dei cambiamenti in atto. Gli stabilimenti, colti nella dimensione di cantieri aperti o di architetture allo stato di abbandono, acquistano in tal senso una valenza particolare, sono espressione di uno stato nel quale velocemente passato, presente e futuro si intrecciano e velocemente si danno il passo. Fissare con la magia dell’obiettivo fotografico il processo del mutamento permette di cogliere atmosfere, elementi naturali e non, che sarebbero altrimenti negate alle nostre possibilità percettive. L’opera Prato, Viale Galilei del 1990, di questa serie, è entrata a far parte, nel 1998 della collezione della Fondazione Malerba di Milano, e nel 2019 della collezione del Centro Pecci di Prato.